L'auto partigiana si imbosca nella Ps 16 di Sassoferrato, deserta nella pioggia, poi in una ex Statale dal nome pazzo di "Septempedana", persa nel polpaccio d'Italia, il punto più largo dello Stivale. Franco è ripartito in treno, l'abitacolo ricomincia a far acqua, viaggia quasi alla cieca finché, in fondo a una gola da assalti alla diligenza, in bilico su una cascata, appare Piòraco, sconosciuto borgo medievale che fa carta da sette secoli e la grazia dell'Onniponente ha risparmiato dalla furia dei geometri. Le sorprese cominciano subito.
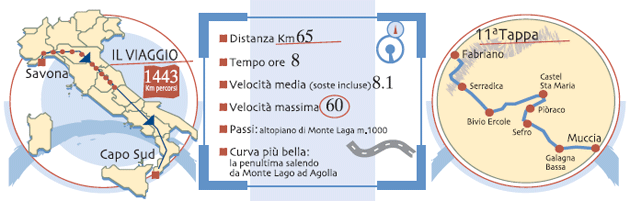
Nel bar sento chiamare una donna "Zobeide". Poi sbuca un "Radames". Troppe, due stranezze in una volta. "Ma come, non lo sapeva?", mi dicono. "Questo è il comune dai nomi più pazzi d'Italia. Vuole sentirne? Brunaldo, Anarchino, Aulo. Ne vuole altri? Guelfo, Pluvio...". Chiedo dove li hanno pescati. "Dai libri. Da dove altrimenti? Siamo un paese di cartai, pieno di libri destinati al macero. Lì ci sono gli eroi che hanno acceso la fantasia di generazioni... Il problema era solo convincere i preti a fare il battesimo... con quei nomi senza santi in paradiso".
Mi raccontano che nel '44 un soldato tedesco venne ucciso a Piòraco da un partigiano jugoslavo, e la gente, nel timore di una rappresaglia, corse dal prete a chiedere consiglio. Quest'ultimo unì genialmente l'astuzia col dovere di buon cristiano. Allestì una camera ardente, ci mise il corpo lavato, rivestito e composto con le armi accanto, aggiunse dei fiori e poi avvertì personalmente il comando della Wehrmacht. Quando arrivò la pattuglia, l'ufficiale si commosse al punto che non ci fu ritorsione alcuna.
***
A Seppio riparo sotto un portico a dar di spugna al pavimento. Non posso continuare, le previsioni sono pessime. Accanto c'è un "bar-alimentari", con un tavolo impegnato in una briscola. I marchigiani sono incalliti battitori di carte. Non c'è locanda, pergolato o stazione dove non ne abbia visti all'opera: alacremente, scientificamente, passionalmente impegnati fin dalle prime ore del mattino. Con qualsiasi tempo.
Tra una mano e l'altra mi chiedono dove vado, da dove vengo, cosa cerco. Un umbro non chiederebbe niente. Un toscano figurarsi. Qui invece sono curiosi, oltre che privi di diffidenza. Mi offrono da bere, si prodigano in consigli. "Vicino c'è un buon alloggio", suggeriscono, "e presto arriva Ginetto che ti può accompagnare lassù". Non mi dicono che Ginetto ha 83 anni e il suo mezzo di trasporto è un'Ape, il più glorioso triciclo da combattimento della storia nazionale.
***
"Questa va dappertutto" scherza Ginetto tirando con la prima su una salita da bestie, "l'Ape ce l'ho da quando che sò natu". Passare da una Topolino a un'Ape è una meraviglia. L'apoteosi, il Te Deum, la celebrazione suprema della lentezza. Il vecchio ha manone da contadino, occhi azzurro-cielo e un eloquio torrentizio. Capisco una parola sì e due no. Lassù c'è il suo campo, lui ci va a zappare ogni giorno. Quanto a me, sono un "cristianu" cui non si nega mai aiuto. "Cristiano", qui, non è un marchio religioso: è sinonimo di forestiero. I marchigiani chiamarebbero così anche un arabo, cristianesimo e ospitalità sono la stessa cosa. Viva le Marche, dove dio è straniero. E Calderoli è lontano come la Luna.
Nel fiume di parole di Ginetto sbuca un certo "Itterle" (accento sulla "i") che deve avere avuto un ruolo nella sua vita, molti anni fa. Itterle, chi sarà costui. "Itterle, Itterle" grida Ginetto per superare l'urlo del motore, "Quello che gli dicevano "aile Itterle!" Capitu?", e per fare il saluto nazista molla non una, ma entrambe le mani dal manubrio nel punto dove la strada compie una curva pazzesca in un asfalto crivellato di buche. Hitler, ordunque. Colui che l'ha mandato in Germania dopo l'8 settembre '43.
Ginetto narra della fame in quel "Paese senza uomini", dove tutti i maschi stavano al fronte. "Itterle era forte - ride - le pensava tutte, i francesi gli avevano fatto la Maginotti e lui gli ha girato attorno". Arriviamo a una frazione di tre case, dove unico abitante è la Bice, altra vegliarda che non molla. Sta sulla finestra, ha sentito il motore, e quando senti una macchina, qui in capo al mondo, non puoi sbagliare. Può essere solo Ginetto, Franco o Giuseppino. Oppure Ulrich, il tedesco che abita trecento metri più sotto.
***
"Adesso ti faccio vedere la tregghia" insiste, e dio solo sa cosa sia la tregghia. Ginetto è su di giri, finalmente ha qualcuno che lo ascolta. Mi porta sotto una tettoia, davanti a una pesante slitta da erba e da neve. "Con questa ho portato le pietre per fare la chiesa", spiega. E indica, poco lontano, una cappella di venti metri per dieci, in perfetto rettangolo aureo, col campanile a vela e una finestrella rotonda sopra l'ingresso e dietro l'abside. Fuori, una gran vista su Camerino e i Monti Sibillini. Prende un mazzo di vecchie chiavi, apre il portone. Dentro, una meraviglia. Sobrie decorazioni affrescate e una presenza arcana nella penombra. Le pietre hanno mille anni, vengono da una chiesa medievale crollata, poco sopra il cimitero. "Ti piace? L'ho costruita per sposarmi. Nel 1947".
Un momento. Ginetto s'è costruito una chiesa da sé. Ha scelto il posto, ha portato una per una le vecchie pietre. Poi, a lavoro finito, ci si è sposato. Sono senza parole. Gli chiedo chi l'ha disegnata. Lui mi guarda strano, come se gli avessi teso un trabocchetto: "Li muratori, e chi altrimenti?". Misuro con un brivido l'apocalisse estetica nel popolo italiano. Chiedo a che santo è dedicata la chiesa. "A Severu", risponde, e smette di sorridere, come se nominasse qualcosa di molto importante. Ma dov'è la statua del santo? E lui, serissimo: "Se l'è portata il prete, anni fa".
Colgo l'occasione al volo. Che nei pensi dei preti, Ginetto? "Io mi fido dei santi", fa lui scansando la polemica. Ora è chiaro: la chiesetta ricostruita nasce da un rapporto personale tra lui e un santo, forse quello che l'ha tenuto vivo in Germania. Severo, conta solo lui. I preti passano, il sacro rimane: e il sacro segna da migliaia di anni la topografia di questa terra di picchi e sorgenti. Mi mostra il paesaggio col bastone. "Dimmi se può esserci un posto più bello", chiede. E poi, gongolante: "Ora vengono le figlie a rifare tutto come staìa". Le figlie? Sì, le studentesse che lavorano al restauro. Fin che c'è Ginetto mangiapreti, Dio abiterà a San Severo.
***
Ulrich, da cui trovo da dormire, abita qui da dodici anni, con la moglie inglese Mary. Ha pollaio e internet, orto e raffinata collezione di libri di viaggio. Nel camino arde un ceppo, due piccoli pastori tibetani dormicchiano accanto. Racconta di suo padre che nel '22 andò a piedi dalla Renania a Napoli; è da allora che l'Italia è entrata nei suoi desideri. Non cambierebbe il suo paesino marchigiano con nessun altro. "Siamo stati accolti come figli, la sola idea di tornare nel grigio del Nord ci fa orrore". Ulrich capisce anche i difetti degli italiani. "Qui c'è un vuoto di memoria", dice. "Pensa, i nostri vicini non avevano idea di abitare in un'ex chiesa longobarda di nome San Michele".
Tramonta, i Sibillini innevati sono un gregge in movimento, indicano l'inizio del grande spartiacque, quello che per millenni separò le due Italie con un invalicabile muro di neve: Adriatico e Tirreno. Mary racconta dei suoi viaggi sovietici ai tempi del Grande Freddo. Telefona per la buonanotte alla Bice, la vegliarda sola, poi va a chiudere il pollaio, perché la volpe passa di sicuro. Sul comodino mi ha lasciato il libro Love and war in the Appennines, amore e guerra negli Appennini, di Eric Newby, ex soldato inglese che sposò la donna trovata nel '44 sui monti della Lunigiana. Sento che il viaggio sta diventando una caccia al tesoro tra eremi, boschi e sorgenti.
Vai all'indice